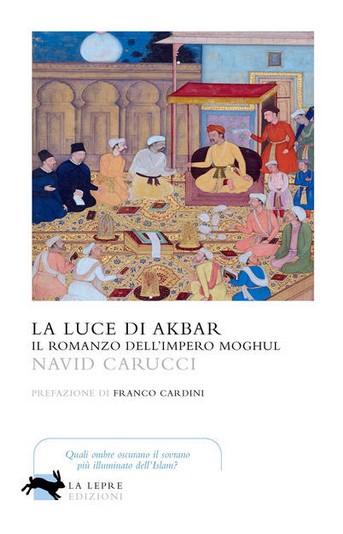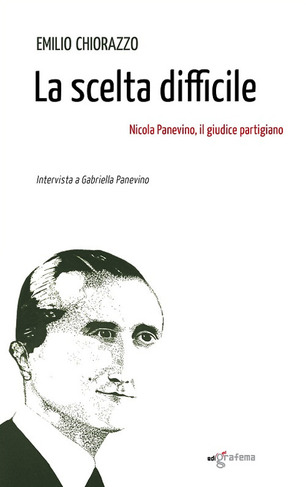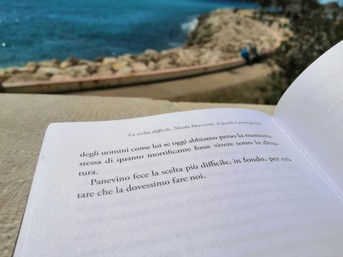...e le letture che proponete voi
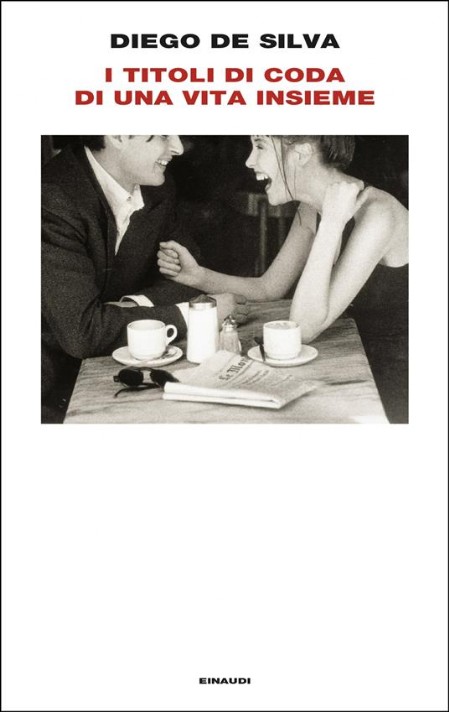
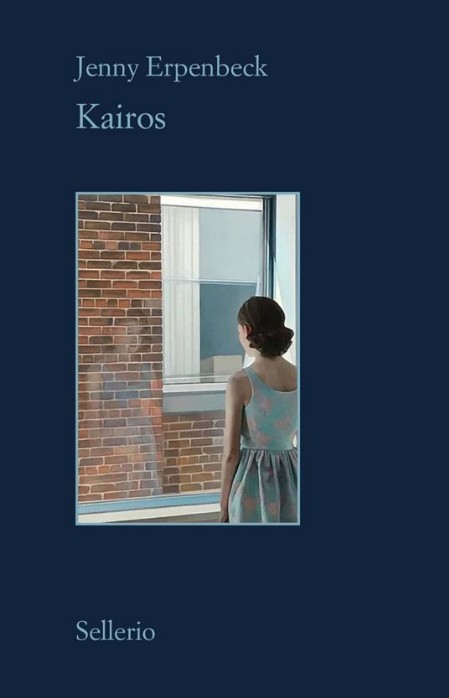

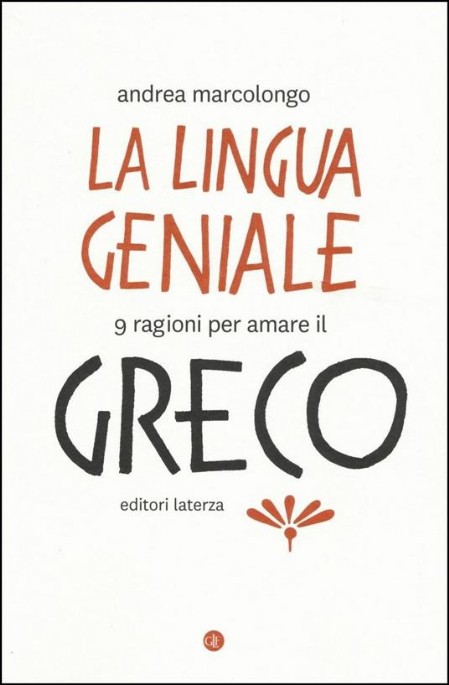

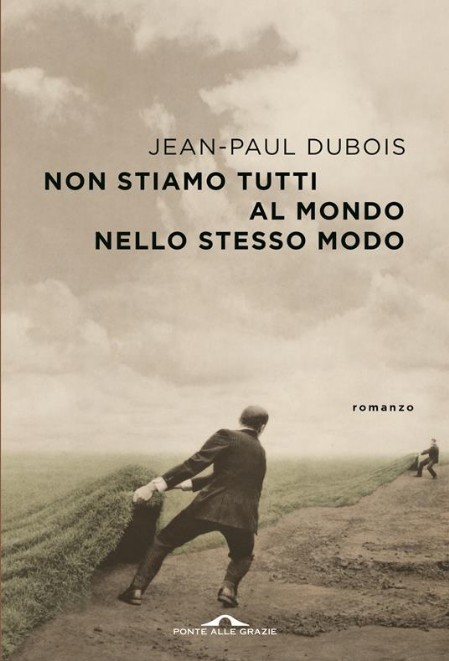

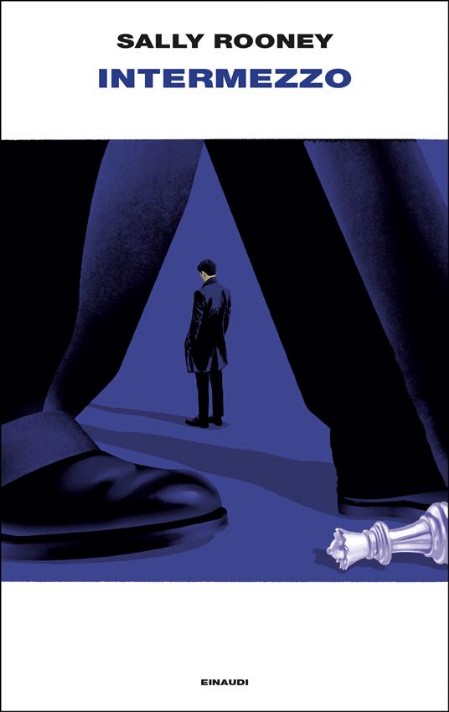
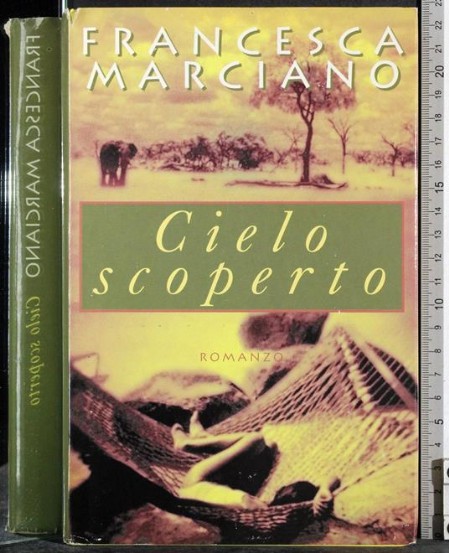
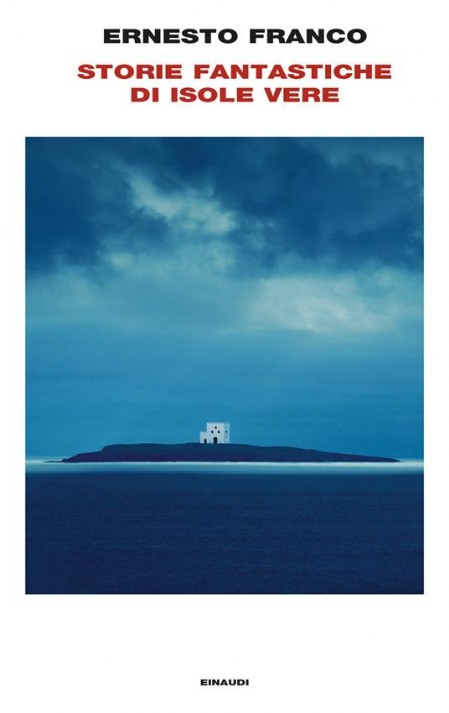
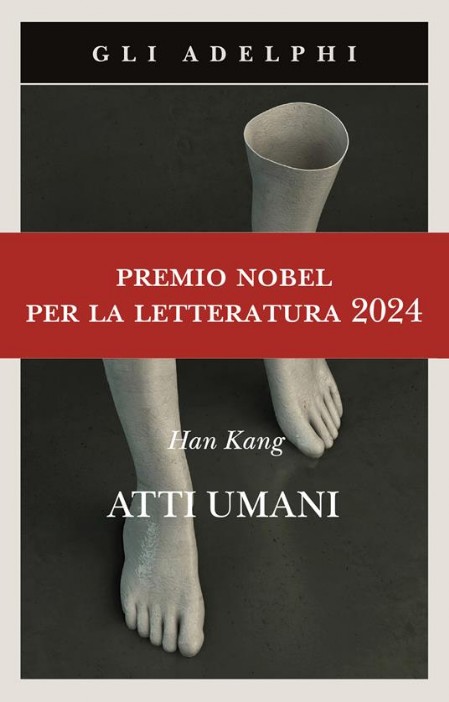


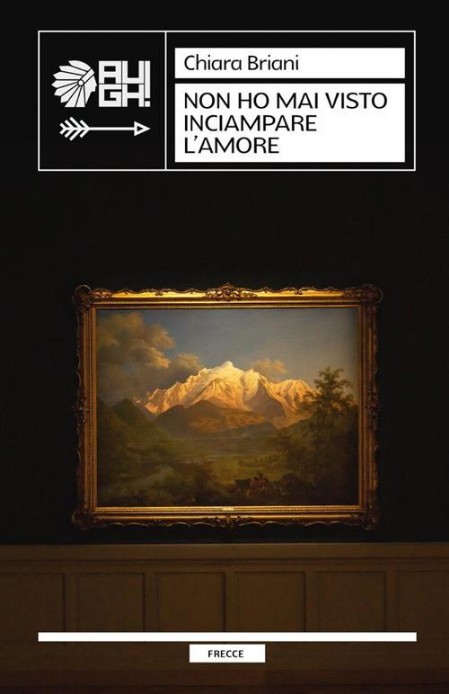
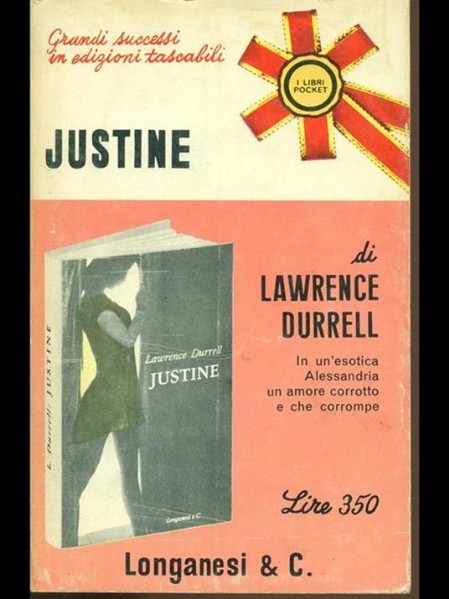


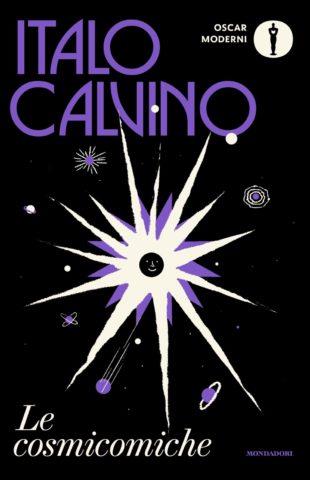

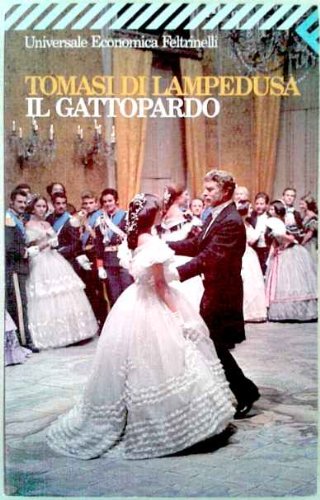
Nelle otto “parti” si descrivono con uno stile raffinato e coinvolgente gli avvenimenti che riguardano l’affascinante figura del Principe Fabrizio di Salina e della sua numerosa famiglia. Si raccontano i mesi trascorsi nell’aristocratica residenza estiva di Donna Fugata dove l’affezionato nipote di don Fabrizio, Tancredi, conoscerà la futura bellissima sposa Angelica, figlia di Don Calogero Sedara, ricco sindaco del paese e rappresentante della nuova classe sociale borghese.
Finisce l’era borbonica e la Sicilia viene annessa al Regno di Sardegna ma l’isola non è ancora pronta né in realtà lo desidera. Tutto cambia affinché nulla cambi. E così Don Fabrizio rifiuta, con riflessioni profonde e realistiche, la carica di senatore del neo regno sabaudo che gli era stata offerta: riflessioni che emergono in tutto il romanzo, sulla vita, sulle stelle, sulla morte e che ci regalano un ritratto della sua amata Sicilia indimenticabile.


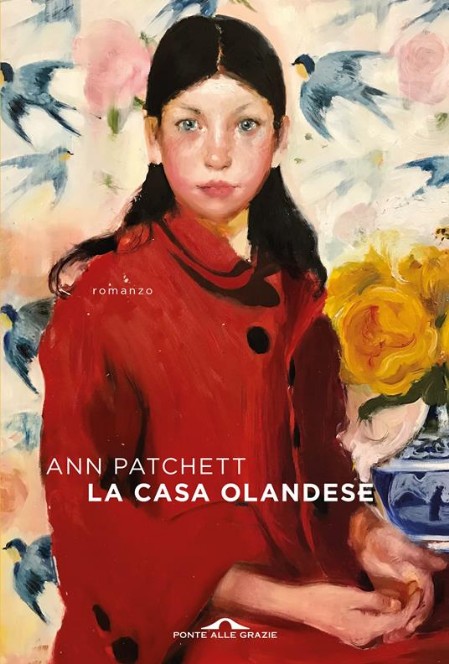
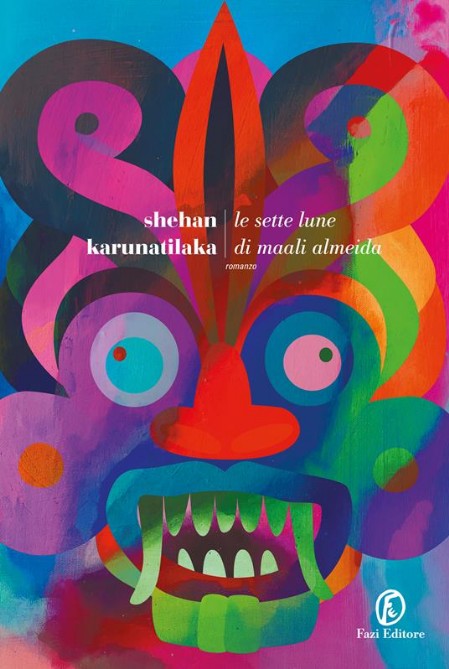

Betta propone (09.05.2024)
Giulio propone (09.05.2024)
Iolanda propone (09.05.2024)
Stefano propone (09.05.2024)
Emma propone (09.05.2024)
Tocca voi proporre qualcosa di nuovo!
Tocca voi proporre qualcosa di nuovo!
Valeria propone (09.05.2024)
Mario propone (09.05.2024)
Otto è uno psichiatra olandese in crisi esistenziale. Matrimonio fallito alle spalle, madre anziana da accudire (senza badanti, a causa di un maledetto guaio che accade all'inizio del racconto; e comunque si tratta di una madre MOLTO particolare, come scoprirete leggendo), grave senso di inadeguatezza sul lavoro. Otto decide di sparigliare le carte, e fare una cosa fuori dalle regole deontologiche per salvare una paziente, e anche se stesso. Ci riuscirà? IL bruttissimo titolo è responsabilità dell'editore italiano.
Stefano propone (09.05.2024)
Emma propone (09.05.2024)
Tocca voi proporre qualcosa di nuovo!