Guido Conforti
I NOSTRI OSPITI

Cara Valeria, cari tutti,
qualche anno fa ho accolto con piacere il vostro invito di presentare “Biarritz” agli Scompaginati.
E’ stata una buona serata; ne ho tuttora un buon ricordo, che mi fa pensare con gratitudine a un gruppo di persone interessate a leggere prima che a scrivere, ad ascoltare prima che a parlare.
Il senso di “Biarritz” si gioca tutto sulla prima frase: “Se per un qualsiasi motivo avessimo la certezza di essere ormai prossimi alla fine dei nostri giorni, qualcuno impiegherebbe un’ora o magari soltanto un paio di minuti del suo tempo residuo per scrivere? E in questo caso, cosa scriverebbe di così urgente? Di così ultimo?”.
Ciò che segue, le 490 pagine del romanzo non sono altro che settanta volte sette pagine che mettono insieme una manciata di esperienza umana, simile a ogni altra che si consuma di fronte al mistero; possiamo leggerle, queste o altre, anzi queste e altre, per stare al gioco della vita. Possiamo anche tralasciarle, dimenticarle, sostituirle, perfino confutarle, o irriderle. Non è importante.
Ma tra quelle pagine e la prima frase sta una risposta possibile alla domanda iniziale, per la quale “si potrebbe ragionevolmente scrivere di un uomo che scrive di un uomo che….”
Si tratta quindi di scrivere non come antidoto, ma piuttosto come testimonianza, lascito, memoria, gesto di sapienza collettiva e quindi di consapevole sopravvivenza della specie di fronte all’anonima scomposizione e ricomposizione del nostro codice genetico. Fare la nostra parte, insomma, più diretti possibile, cercando di non barare, fino in fondo.
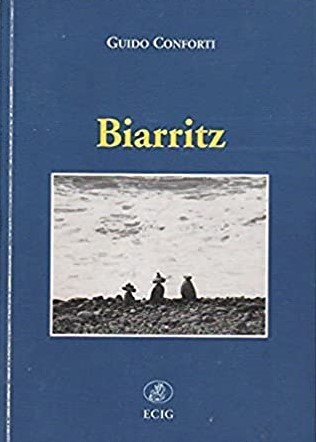
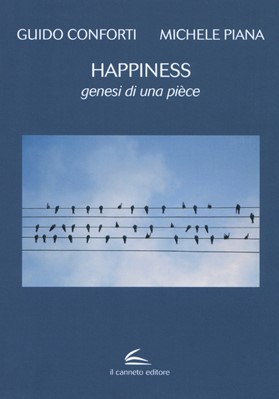

Per quanto mi riguarda, la naturale discendenza di “Biarritz” è stato lo spettacolo “Happiness” (compreso l’omonimo librino edito dal Canneto, che riporta genesi e soggetto della pièce), nel quale con Michele Piana abbiamo girato intorno a questo tema fondamentale, così caro e comune a tutti noi, senza distinzione; così evocativo, eppure così sfuggente.
Nel coinvolgere il pubblico a cimentarsi con la sfida al Fantacalcio tra le squadre di chi ritiene che la felicità sia uno stato oppure un moto, abbiamo provato a scalfire il pregiudizio che la felicità non sia altro che una reazione biochimica, oppure un’illusione, perfino una truffa, magari una forma particolare del piacere, del benessere, della soddisfazione, perfino della beatitudine.
Prima che il sipario si richiuda sulla teoria di settanta volti fotografati nell’attimo in cui il flash della felicità ha attraversato una coscienza, la nota finale dell’Intermezzo op. 118, n. 2 di Brahms suonato da Michele si consuma su una scritta a tutto schermo: “Felicità è tornare a casa”.
Nella nostra esperienza questa conclusione, apparentemente così categorica, precisa, definitiva e al tempo stesso generica se non addirittura ambigua, sembra toccare qualche corda profonda nell’anima degli spettatori, molti dei quali hanno trovato il modo per interpellarci di persona proprio su questo punto.
Ma di quale casa stiamo parlando? Abitata da chi? Perché ce ne siamo andati? E perché fare ritorno? Ma è possibile fare ritorno? Per trovare o ritrovare cosa? Chi?
Una casa in cui si resta senza altra prospettiva che di trattenersi senza fine, è uno stagno gelato, un sepolcro, un sipario richiuso sulla scena della vita.
Bisogna uscire, quindi: andare, immaginare, osare, provare, magari sbagliare, perdere, perdersi, riprovare, camminare, scalare i versanti più impervi o calarsi negli abissi più bui, incrociare traiettorie, parole, disegni, connettersi, connettere, creare, seminare, sbagliare, perdere, perdersi, riprovare, raccogliere, ritrovarsi, ritrovare la via di casa e alla fine tornare a casa.
Alla fine di ogni giro, lungo come un giorno o una vita intera, tornare a casa diversi; felici perché a casa e perché diversi. Un divergere e un convergere che partano e facciano ritorno ogni volta alla porta carraia della propria casa.
Aristotele chiama “enteléchia” questo atto supremo della vita: l’attuarsi delle potenzialità insite in ogni individuo, il compiersi del viaggio, quanto meno di ogni tappa di cui il viaggio dell’esistenza si compone; ciò di cui l’uomo, a differenza della quercia o del cavallo, ha modo di accorgersi e di compiacersi.
In tutti questi casi e nei mille altri che potrebbero aggiungersi di atti che chiudono il cerchio (o un primo cerchio) di enteléchia, si fa esperienza di qualcosa che siamo soliti assimilare alla felicità e che dura appena il tempo di accorgersene, mentre l’universo e la vita in esso sono già passati altrove. Da qui la necessità di non cedere alla tentazione di fermarsi e di iniziare invece un altro viaggio, un’altra divergenza del pensare, del fare e dello stare, con l’orizzonte di una nuova convergenza, una nuova sintesi, una nuova creazione, una nuova esperienza di felicità.
E così via, un’onda dopo l’altra, un andare per ritornare con sempre qualcosa di più: il pensiero pensato, la parola scambiata, il fatto causato, l’inesistente generato.
Tutto questo è trasposto mirabilmente nel Faust di Goethe.
L’umanità di Faust si gioca nella ricerca del suo senso, che non sta né nella conoscenza, né nella capacità di guarire i malati e i bisognosi, né nel sentimento di appartenenza a un tempo, a un luogo, a una gente.
La Felicità non sta in nessun “attimo”, ma si sostanzia nel farsi continuamente di ogni cosa secondo la sua enteléchia. E’ l’Ewig-Weibliche, l’ “eterno femminino” che chiude il Faust nel Coro mistico alla conclusione del quinto atto.
Tutto il divenire dell’esistenza è quindi un farsi, dalla potenza all’atto.
E’ una continua generazione, che tutto aggiunge e nulla perde o annienta.
E’ una parola che nell’atto di scambiarsi crea una realtà prima inesistente.
E’ un eterno dialogo, è un multiverso.
guido